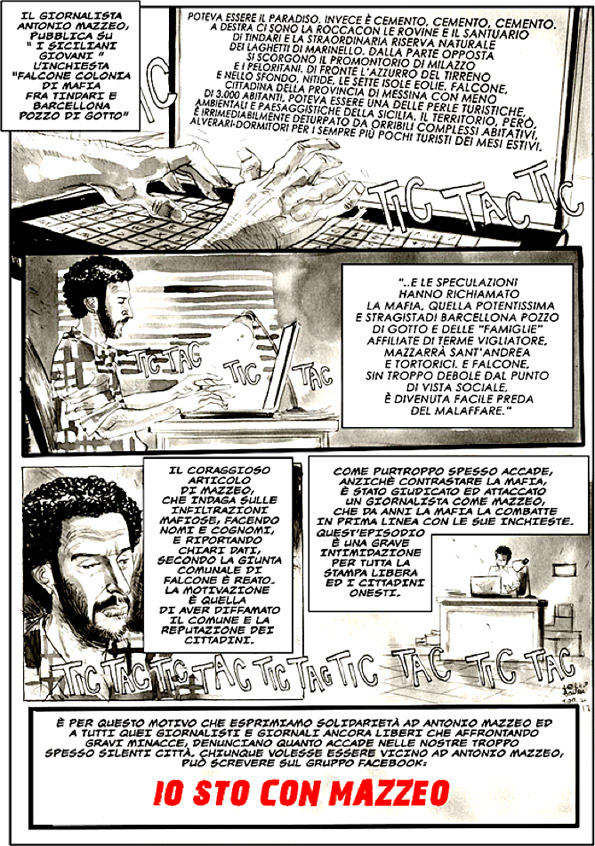Quando il femminismo disse sì al potere
La globalizzazione aggiunge, però, un dettaglio ancora più preoccupante: spinge a volgere lo sguardo verso la dimensione locale, cosicché gli argomenti sulla donna interessano nella misura in cui riguarda il quartiere, la famiglia, il corpo e la tasca (un fatto che presumibilmente accadrà quando la violenza contro le donne sarà formalmente dichiarato un problema di salute pubblica).
In una conferenza su donne ed aggressioni indirizzata ad un pubblico costituito da genitori di alunni adolescenti, quando dissi che une delle realtà più brutali era che l’85% della popolazione mondiale femminile passa 24 ore al giorno cercando acqua potabile, le madri mi risposero che il problema non le riguardava.
Allora capii: naturalmente, il loro problema erano le figlie violentate dal futuro marito o vittime di insinuazioni oscene sul lavoro.
L’adesione malaticcia al quartiere, alla casa come patria, senz’altro ci inabilita per la solidarietà, giacché la solidarietà richiede una proiezione etica che lo spirito ristretto di quelle madri pusillanimi non potrebbe mai avere.
L’Africa è tanto lontana… che ce ne frega? Ci interessa l’uguaglianza, certo, ma a casa nostra. Effetti collaterali della globalizzazione.
Ma l’aspetto più inquietante è che quelle che si definiscono femministe applichino gli stessi sistemi di esclusione che di sicuro avranno passato anni a tentare di combattere. L’industrializzazione capitalista significò la nascita di un’elite basata sul benessere e il potere. In tale distribuzione la donna guadagnò un certo benessere e rimase esclusa del potere.
Adesso il problema del potere è risolto, e il benessere ora non è solo uno status ma un argomento di stato. Stato di benessere a costo di grande malessere. In questo momento non bisogna lottare: il potere acetta di buon grado che un certo femminismo mansueto si accordi con il bagliore delle sue file più progressiste.
Sarà forse perché le armi del debole sono armi deboli, come afferma Lucien Bianco? O piuttosto succede quello che si denominerebbe, in una sociologia un pò casalinga, “la forza della struttura” che spiega, da un lato, il fenomeno per il quale i dominati applicano ai loro rapporti categorie create dai loro dominatori e, dall’altro, la sconfitta che con magistrale splendore descrive Mary McCarthy nel suo libro “Il gruppo”, con quelle donne relitti di molti naufragi e destinate alla frustrazione irrevocabile.
So bene che sto distruggendo il festival trionfalistico che tutti sperimentiamo con ubriachezza crescente: il peggio che si può fare in tempi di frivolezza gioiosa è la parte del guastafeste, ma credo anche – con la fermezza di chi si ostina, malgrado tutto, a pensare che fra tanta mendacia si dobrebbe avere un’intenzione, se non buona, almeno meno brutta- che se il sonno della ragione produce mostri, quello del torto produce carne macinata per i cani e tutti, volenti o nolenti, finiamo per divorarne un pezzo ed alimentarcene.
Mi si obietterà che non è così grave, che le donne di oggi siamo bene rappresentate.
Sono d’accordo, si potrebbe persino aggiungere, senza timore di sbagliare, che siamo sovra-rappresentate, ma quella rappresentazione non parte più dalla critica ma dall’autocompiacimento, cosicché questo femminismo rappresentativo rappresenta sé stesso, logicamente d’altra parte, poiché è cresciuto all’ombra di un’idea della democrazia che alla fine rappresenta sé stessa davanti ad un argento vivo immaginario.
Questo nuovo classismo esibito dal potere appena inaugurato, questo totalitarismo di una discriminazione velata e dell’eufemismo facile, questa democrazia limitate dalle sue stesse bugie ed incapacità… ci causerà più preoccupazioni. E parlare di dignità sarà un gioco ormai vecchio e scomodo, il sintomo più puro del cinismo.