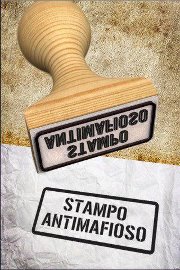Il paese perduto
Diario di una vita antimafia
L’urlo della storia squarciò il vuoto in cui eravamo sprofondati. Sembrava il coro di una tragedia greca, un coro fatto dagli onesti che in quel preciso istante, senza conoscersi, dai punti più disparati della Nazione, emettevano il loro urlo di dolore mentre le terribili immagini dell’asfalto saltato in aria, di quell’orrendo vulcano di catrame, dei brandelli di Giovanni e di Francesca e degli agenti della scorta, scorrevano alla tivù e il regime ci imboniva con i suoi programmi di evasione.
Tutto si rivelò chiaro in quell’abbagliante giornata di primavera del Millenovecentonovantadue, mentre un sole caldo inondava questa Sicilia ammorbata e mi confermò che se volevamo salvare questo Paese dovevamo esporci, anche a costo di rimetterci la pelle. Fu quel tremendo urlo a svelare una semplice verità che l’indifferenza, il cinismo e la complicità di tanti avevano nascosto.
Ci eravamo illusi di stare in un sistema democratico ma in realtà vivevamo in un regime in cui la corruzione era diventata l’essenza della nostra esistenza.
Fino a quando una cosa del genere dura quattro, cinque anni è estirpabile, ma quando si perpetua per almeno vent’anni, si cristallizza nelle teste di tanti ed è impossibile sradicarla.
Ogni volta che questo Paese ha cercato di voltar pagina, ogni volta che ha cercato di darsi una svolta democratica, un botto ha squarciato i tentativi di cambiamento e tutto è tornato come prima, piazza Fontana, Brescia, l’Italicus, Bologna, dalla Chiesa, Chinnici, La Torre, Moro, Mattarella, e ora Falcone, un sottile filo ha sempre accomunato stragi politiche e stragi mafiose. Ma stavolta era diverso. Stavolta la collera degli onesti, gli urli straziati e strazianti della vedova Schifani e degli altri familiari e della gente comune che durante i funerali inveiva contro i politici, squarciavano il silenzio della cattedrale.
Stavolta era diverso perché avevano lanciato pure le monetine a Craxi davanti all’hotel Raphael.
E c’era questa collera, questo urlo disperato degli onesti che reclamavano verità e giustizia. Ricordo le manifestazioni per commemorare Falcone, la sala strapiena di gente, e poi giugno e luglio, il lutto che piano piano ci scivola addosso fino ad asciugarsi.
Una giornata di mare con gli amici, io che faccio i soliti discorsi intrisi di rabbia e di indignazione, e qualcuno che mostra la solita insofferenza, Sempre-sti-discorsi-di-mafia-e-di-politica, e io che voglio gridare, voglio scappare, voglio piangere, ma alla fine stringo i denti, ricaccio le lacrime e faccio finta di vivere perché alla fine tutto si riduce in questa assurda finzione imposta dal fatto che devi vivere.
E-allora-ce-lo-facciamo-questo-bagno? In fondo il problema di questo Paese non è solo il fatto che saltano in aria i magistrati, è questa lotta sorda, furibonda e selvaggia contro la stupidità e l’opportunismo degli uomini. Il problema è che dobbiamo adeguarci perché siamo infinitamente di meno. E allora facciamolo questo fottutissimo bagno e scherziamo, e poi un altro bagno e poi un’altra battuta, e poi facciamole quelle interminabili discussioni su crociere, alberghi con piscina, villaggi turistici dove si mangia di tutto e quando torneremo alla vita di ogni giorno sarà la stessa cosa, una eterna giornata di discorsi vuoti e di risate… Dobbiamo rimuovere in fretta. Dobbiamo vivere, anche se attorno a noi si avverte il ghigno malefico della morte. Dobbiamo far finta di niente.
Adesso siamo sulla via del ritorno in questa afosa giornata di luglio, a due mesi dalla strage di Capaci. C’è una calca indescrivibile in autostrada, in macchina non c’è l’aria condizionata e si suda, io nel frattempo ho assorbito il colpo della mattina, o forse mi illudo che tutto sia passato, vivo con un costante magone e con un groppo in gola e faccio finta di adeguarmi ai discorsi della gente dabbene.
In fondo abbiamo elaborato il lutto e ora possiamo permetterci di parlare del nulla, ascoltare musica mentre camminiamo a tre all’ora per quei maledetti lavori in corso.
Improvvisamente dall’altra macchina arriva ansimando un amico: “Hanno ammazzato Borsellino”. Risento quell’urlo, questa volta più veemente. Ormai in questo Paese le parole non bastano più, ci vuole il botto per far capire alla gente perbene che tutto sta andando in malora. Sulla macchina cala un silenzio di tomba, non si parla più di niente, non si ride più di niente, si spegne lo stereo e si fa ritorno a casa.
Accendo la televisione, Palermo sembra Beirut, i palazzi sventrati e le macchine divelte, i vigili del fuoco che cercano di spegnere gli incendi e tanta gente che gironzola in via D’Amelio e forse in quel momento la telecamera inquadra il tizio che sale sulla macchina di Borsellino per prelevare l’agenda rossa, ma noi vediamo solo persone che gironzolano in questa strada anonima circondata solo da palazzoni costruiti negli anni Sessanta.
E poi risenti quell’inconfondibile urlo che sembra uscir fuori dal quadro di Munch, questo simbolo dell’angoscia e dello smarrimento umano che vedo senza vedere, e sento senza sentire, e a un certo punto ricordo per filo e per segno le parole del pittore norvegese e lo stato d’animo straziante che è lo stesso che provo io adesso, quando descrive le sensazioni dell’Urlo: “Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue…”.
La giornata non è ancora finita. Qualche ora e cala la sera. Ormai tutto il mondo sa che hanno fatto a pezzi Borsellino e i suoi agenti della scorta. A un certo punto, da lontano, sento un coro di clacson, mi affaccio e vedo delle macchine che si avvicinano, e quel coro che diventa sempre più assordante. Le auto si fermano in piazza, scendono una quarantina di giovinastri, stappano le bottiglie di spumante e intonano dei cori da stadio, saltano, urlano, inneggiano alla loro squadra di calcio che oggi ha vinto il campionato, una danza tribale macabra, senza fine.
“Il paese perduto” di Luciano Mirone, di prossima pubblicazione, racconta la mutazione italiana attraverso storie di gente comune