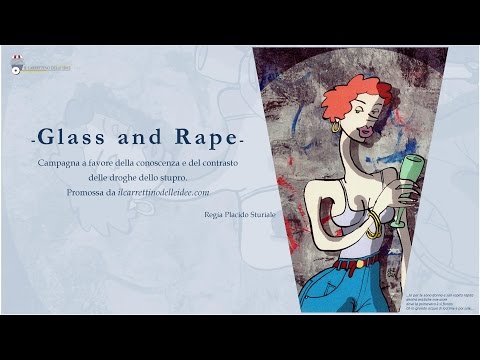Gli uomini mangiano i pesci
E i pesci mangiano gli uomini, e qualcuno ci specula su…
Lo scorso 3 luglio il Teatro Stabile ha affidato a Lucia Sardo e a Simonetta Cartia il reading del progetto teatrale “Gli uomini mangiano i pesci”, iniziativa promossa con la collaborazione del Comune di Catania.
La bozza di spettacolo verte sull’ecatombe che tutti i giorni, da anni ormai, avviene nel Mediterraneo. Il titolo nella sua semplicità racchiude del macabro: se una volta erano gli uomini che mangiavano i pesci, oggi sono i pesci che si nutrono dei corpi di tutti quei profughi che il mare accoglie nel suo grembo, perché quella terra, la nostra terra tanto agognata, non è in grado di fare altrettanto: e invece che simboleggiare la speranza diventa sinonimo di sepoltura, di morte.
Un tema delicato da trasporre sul palcoscenico ma, sebbene l’analogia tra i pesci e gli uomini sia azzeccata, probabilmente il rischio di banalizzare l’argomento non si è riuscito ad evitare.
Lo spettacolo si apre e si chiude con una nenia cantata dall’attore tunisino Jean-Jacques Lemàtre nella sua lingua madre, unico tocco di autenticità alla messa in scena: paradossalmente proprio questa canzone popolare che parla di amore e che è assolutamente incomprensibile perché cantata in arabo riesce a racchiudere tra le sue parole misteriose il bisogno di speranza di interi popoli, più di quanto riesca a fare il dialogo tra le amiche Miriam e Vita, più delle foto che scorrono sullo sfondo, più della scarna scenografia.
Anche se la recitazione delle due protagoniste è vivace, il contenuto proposto rimane troppo tiepido: Miriam e Vita sono due amiche che hanno condiviso parte della loro vita, anche grazie all’amicizia che legava i loro padri, comproprietari della tonnara in un isolotto al largo di Lampedusa.
La vita le lega attraverso il mare, attraverso il rito della mattanza che hanno vissuto durante l’infanzia. Dopodiché mentre Miriam decide di rimanere nella propria terra, Vita si trasferisce nel nord Italia e le differenze tra loro non fanno che acuirsi: il loro dialogo diventa un continuo ping pong tra la logica xenofoba di Vita e la logica di diritto alla vita di Miriam. Le domande retoriche si sprecano, le due donne si contrappongono, si scontrano, si intrecciano… in un continuum che non trova nessuna risoluzione.
Le foto di Stefano Fogato scorrono sullo sfondo e rappresentano le facce dure e abbronzate dei pescatori di Favignana durante il rito della mattanza: la prima foto è agghiacciante perché è un cartello con su scritto il numero di tonni pescati e rievoca i numeri di profughi morti cui assistiamo quotidianamente, ormai con una certa assuefazione.
La scenografia è semplice, quasi inesistente, visto che si tratta di una semplice lettura di copione: un cavallo a dondolo a ricordare l’infanzia, un tavolo con su una Madonna, due sedie, due leggii.
Si sfiora la rappresentazione dell’eterna lotta dell’uomo con la natura: un tempo erano i pescatori che sfidavano il mare per garantirsi la sopravvivenza, oggi sono i profughi che lo sfidano per lo stesso motivo, sebbene con due modalità diverse.
Si dà per scontato che ormai l’unica via possibile sia questa: la morte. La speranza non traspare. E’ come se il mare fosse destinato per forza di cose a divenire una tomba: di pesci o di uomini è indifferente. Non è un testo di denuncia civile perché non si fa nessun accenno alla responsabilità dei governi, dello Stato, dei singoli cittadini.
E’ uno spettacolo in cui manca del tutto una presa di coscienza e quindi piuttosto che denunciare non fa che riproporre le posizioni dualistiche cui assistiamo spesso nei talk show televisivi: una passerella di idee politiche che si contrappongono per il piacere di portare acqua al proprio mulino, senza la benché minima intenzione di volgere lo sguardo alla questione umana, alla tragedia vissuta da migliaia di uomini, donne e bambini.
Sì, certo, aver cercato di poeticizzare questo tema è stata una trovata astuta ma si è fatto in modo tale che non avrà alcun riscontro sulla realtà: questo tipo di teatro non denuncia, non urla, non si indigna. Ridipinge la realtà con pennellate sfumate che non fanno che offuscare ancora di più la percezione del dramma trasposto sul palcoscenico.
E tutto ciò addolora lo spettatore, ma addolora ancora di più l’essere umano che assiste doppiamente inerte a questa tragedia: prima a quella reale, poi a quella speculatrice del teatro.
“Gli uomini mangiano i pesci” non si può definire uno spettacolo catartico: non ripulisce dalle emozioni negative, non propone nuovi orizzonti, non fa venire voglia di lottare. Piuttosto narcotizza in una visione romantica tra passato e presente, suggestiva sì ma per niente costruttiva.
E tutto ciò è tristemente confermato quando una volta finito lo spettacolo, il nostro caro sindaco Bianco sale sul palcoscenico per ringraziare gli attori e si crogiola in una serie di dichiarazioni istituzionali sul tema immigrazione: – “Grazie alla generosità del governo centrale abbiamo recuperato i profughi del naufragio dello scorso aprile… E siccome siamo “buoni” daremo loro (persino) una sepoltura, perché noi siamo accoglienti!”.
Il sangue gela: noi siamo accoglienti? Ma il nostro compito è accogliere i morti o fare in modo che approdino su questa terra vivi, e con le loro speranze intatte? Su questo non spende una parola. Troppo scomodo farlo.
L’umanità, ecco cosa manca. Manca nello spettacolo, manca nelle istituzioni, manca tragicamente negli esseri umani. Tuttavia la speculazione sul dolore non manca mai, ed è sempre più frustrante.