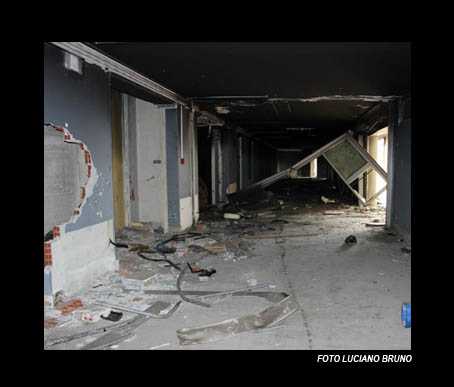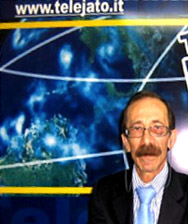I “collaboratori” collaborano. E lo Stato?
L’istituto della collaborazione con la giustizia degli ex appartenenti ad associazioni mafiose costituisce uno dei principali strumenti di contrasto alla mafia
Per collaboratore di giustizia s’intende chi, dopo aver fatto parte di una organizzazione criminale, decide di dissociarsene e di collaborare con l’autorità giudiziaria.
In Italia la creazione della normativa è stata determinata dalla situazione politico-giudiziaria della fine degli anni sessanta, quando ripetuti atti di violenza crearono grande allarme sociale. Ma soltanto negli anni novanta è stata introdotta una disciplina specifica in materia, grazie al decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, i cui punti più importanti erano:
– poter fornire uno speciale programma di protezione ai collaboratori di giustizia e ai parenti più prossimi e permettere al collaboratore di accedere a vari benefici penitenziari (tra cui misure alternative alla detenzione)
– il programma di protezione doveva essere deciso da un’apposita Commissione (istituita dal Ministero dell’Interno) e doveva essere richiesta dal pm, dal prefetto
o dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
– l’ammissione dipendeva dalla gravità e attualità del pericolo, dall’importanza delle informazioni fornite e dall’adempimento degli obblighi previsti dal programma di protezione stesso;
– la gestione e l’attuazione dei programmi di protezione era affidata a un servizio istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno (Servizio centrale di protezione);
– il Ministro dell’Interno, in casi eccezionali, poteva autorizzare il cambiamento delle generalità dei soggetti sottoposti al programma di protezione.
Questa legge è stata poi modificata con la successiva del 13 febbraio 2001 n. 45, con cui s’è cercato di eliminare le disfunzioni e incongruenze della precedente.
È stato fortemente limitato il numero dei soggetti sottoposti al programma di protezione: ne possono usufruire solo coloro che forniscono un contributo di notevole importanza, mentre la collaborazione può essere portata avanti soltanto nell’ambito di alcune gravi fattispecie di reato attinenti alla criminalità organizzata (come ad es. terrorismo o eversione).
Solo notizie attendibili e complete
Il soggetto viene ammesso al programma di protezione solo se le notizie sono nuove, complete, attendibili e rese al pm entro 180 giorni dalla dichiarazione di volontà di collaborazione, oltre al fatto che all’autorità giudiziaria devono essere consegnati beni e denaro di provenienza illecita.
Infine viene introdotta una netta distinzione tra collaboratori e testimoni di giustizia (soggetti vittima di reato o persone informate sui fatti destinate ad una diversa protezione).
Nel 2013 l’allora Presidente del Consiglio Enrico Letta aveva istituito, tramite decreto, una Commissione col compito di elaborare proposte di modifica al sistema per la lotta alla criminalità organizzata.
La Commissione, composta dal Presidente Roberto Garofoli e dai membri Magda Bianco, Raffaele Cantone, Nicola Gratteri, Elisabetta Rosi e Giorgio Spangher, dopo aver ascoltato anche il parere di diversi soggetti coinvolti, è approdata alla stesura del “Rapporto della Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità” nel quale vengono sollevate criticità sul sistema normativo vigente.
Un primo profilo riguarda il rigido termine previsto (180 giorni) entro il quale bisogna concludere l’assunzione delle dichiarazioni da parte del pentito: quelle successive sono inutilizzabili (salvi alcuni correttivi) e non è prevista alcuna proroga. Secondo la Commissione questo termine è eccessivamente rigido, considerata anche la mole di lavoro esistente nelle Procure.
La proposta consiste nell’introdurre una proroga per il pm che dimostri di aver svolto la sua attività lavorativa ma di non essere riuscito ad assumere tutte le dichiarazioni del collaboratore, oltre a quella di creare una sanzione di inutilizzabilità per le dichiarazioni tardive, a meno che non si dimostri che il ritardo sia tale per un giustificato motivo.
Le misure di protezione
Un secondo profilo riguarda il numero di componenti della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione: la legge del 1991 prevede due magistrati e cinque funzionari e ufficiali, presieduti da un Sottosegretario di Stato.
La Commissione propone di aumentare il numero dei magistrati da due a quattro.
Il terzo profilo di criticità riguarda infine il sistema della partecipazione a distanza al dibattimento dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Questi ultimi riferiscono diverse informazioni relative ad episodi delittuosi e queste instaurano diversi procedimenti penali: il soggetto deve perciò rendere le sue dichiarazioni in più giudizi, ma ciò genera ingenti spese allo Stato, che si deve occupare dei singoli trasferimenti. Questa situazione ha portato all’uso nei processi della videoconferenza.
La videoconferenza
Si deve inoltre distinguere se all’interno dei processi il soggetto partecipi come imputato o testimone: a seconda della posizione ricoperta nel processo infatti, il soggetto può o non può rendere la propria testimonianza a distanza, situazione dipendente anche da ragioni di sicurezza ed ordine pubblico. Per questo motivo il giudice deve disporre le cautele necessarie affinché il soggetto non sia riconoscibile ed evitare possibili ripercussioni da parte degli imputati.
La Commissione ha perciò proposto di rendere obbligatoria la videoconferenza, anche se il collaboratore o il testimone sia esso stesso un imputato: questo servirebbe per ridurre notevolmente l’onere economico per lo Stato e per l’incolumità sia dei soggetti protetti sia per gli operatori di polizia addetti alla scorta.
Scheda
PENTIMENTI, GIUSTIZIA E VERITA’
Partiamo da un dato: senza i collaboratori di giustizia non sapremmo tutto quello che oggi sappiamo sulle mafie. Non sapremmo i rapporti al loro interno, i riti, i misteri e le verità. Probabilmente dubiteremmo ancora dell’esistenza della mafia. Eppure, questi, nascono col nascere delle mafie nonostante solo con Falcone diventino uno “strumento” fondamentale nelle mani della giustizia. Sicuramente hanno avuto un ruolo di primaria importanza nella lotta al terrorismo, ma quella, come ben sappiamo, è un’altra storia.
Il primo pentito di mafia nella storia d’Italia «si chiamava Salvatore D’Amico. A metà dell’Ottocento faceva parte della “fratellanza degli stuppagghieri” di Monreale. Si trasferì a Bagheria, la cui cosca, “i fratuzzi”, era in guerra con quella monrealese. Iniziò a temere per la sua vita e decise di dire quello che sapeva ai giudici. “Undici giorni dopo il D’Amico veniva trovato crivellato da lupara, con un tappo di sughero in bocca (‘u stuppagghiu) e sugli occhi il santino di stoffa della Madonna del Carmine che i fratuzzi portavano al collo a mo’ di amuleto e riconoscimento. La mafia aveva ritrovato l’unità per punire il traditore, anche se le due cosche continuarono per anni a distruggersi a vicenda”».
Melchiorre Allegra, medico trapanese “pentito” nel 1937, era «affiliato alla famiglia mafiosa palermitana di Pagliarelli. Aveva raccontato la struttura di Cosa Nostra, il rito della “punciuta”, i nomi delle famiglie più importanti e i legami con la politica, la sanità e gli affari».
Tra D’Amico e Allegra intercorrono storie di pentitismi, collaborazioni e confidenze. Nei verbali venivano chiamati “dichiaranti” ma le scarse norme legislative sul tema e le diverse condizioni storiche del tempo hanno lasciato poche tracce delle testimonianze di questi personaggi. Difatti le notizie sono scarse sulla storia del pentitismo prima di Leonardo Vitale. Un “pentito” vero, quest’ultimo. Rese dichiarazioni spontanee dopo una lunga e travagliata riflessione, cercava un ravvedimento, voleva rimediare per il male fatto così come insegna il catechismo della Chiesa Cattolica. I collaboratori da ricordare, per importanza e verità, non sarebbero pochi. Ci sarebbe da raccontare anche di quei “falsi pentiti”, orchestrati a dovere per confondere le carte in gioco e creare sfiducia in questo strumento.
Collaboratore però, non è sinonimo di “pentito”. Ognuno di loro è mosso da un motivo diverso che li porta a collaborare con la giustizia. I soldi, la protezione, o forse un riscatto per il male fatto. Spesso considerati dei delatori, che poi è il peccato di Giuda (e il paragone, non mio, è tristemente infelice), sono da sempre osteggiati e criticati dalla pubblica opinione e da molti addetti ai lavori. Eppure costituiscono un pilastro fondamentale della lotta alla mafia. In questo paese, e non solo. Forse basterebbe proteggerli maggiormente, seriamente, in base alla storia e alle verità riscontrate e non trattarli tutti allo stesso modo.
Del resto, da D’Amico, a Buscetta, fino ad arrivare a Iovine, è cambiata la mafia, non il modo di trattare e “usare” i collaboratori di giustizia. Almeno fin quando questi, si limitano a portare verità che non fanno male a molti.
Salvo Ognibene